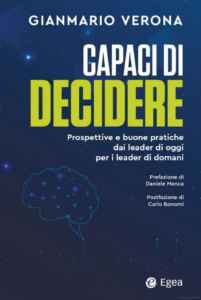di Elena Gadeschi
Che caratteristiche deve avere un buon leader? I tedeschi lo chiamano zeitgeist, una parola che si può tradurre come “spirito del tempo” e che va a definire le idee, le convinzioni e lo stato d’animo che permeano un particolare periodo storico. Un buon leader non può prescindere dalla conoscenza dei suoi tempi e, in particolare, di sei fattori che modellano la realtà contemporanea, individuati dai docenti Nitin Nohria, dal 2023 presidente e amministratore non esecutivo senior di Exor, e Anthony Mayo, Senior lecturer of Business administration alla Harvard Business School: eventi globali, intervento governativo, relazioni sindacali, demografia, costumi sociali e panorama tecnologico. Partendo da un loro studio condotto oltre vent’anni fa per Harvard Business Review sulla leadership, confluito nel libro In Their Time. The Greatest Business Leaders of Twentieth Century, nel 2022 i due autori spiegavano che i grandi leader sono «definiti meno da tratti duraturi e più dalla loro capacità di riconoscere e adattarsi alle opportunità create da un particolare momento». «Una leadership efficace, in altre parole, è in gran parte specifica del contesto: la stessa persona che ha successo in un’epoca potrebbe fallire miseramente in un’altra» e «gli individui che sono in grado di riconoscere i cambiamenti in questi fattori e di sfruttarli hanno ciò che chiamiamo “intelligenza contestuale”».
La guerra in Ucraina prima, il conflitto israeliano-palestinese poi, hanno mostrato come eventi geopolitici apparentemente localizzati possano avere profonde implicazioni per i leader aziendali. Lo si è visto con le sanzioni imposte dall’Europa e dagli Usa alla Russia, una scelta che ha comportato considerazioni morali, economiche e politiche e alcuni amministratori delegati non sempre si sono sentiti preparati a valutare. Come scrivono gli autori per Harvard Business Review, è necessaria «una maggiore enfasi sulle capacità di gestione delle crisi. I leader non possono più dare per scontato che i problemi possano colpire una volta ogni tre o quattro anni ed essere gestiti da consulenti esterni per le crisi. Al contrario, le aziende devono prepararsi a un flusso costante di sconvolgimenti e affinare le proprie competenze interne per affrontarli. Non possono permettersi di limitarsi a reagire; dovrebbero anticipare, pianificare e organizzare le potenziali sfide». Implicazioni potenzialmente deleterie possono avere anche i grandi movimenti di attivismo per il clima, i diritti umani, la parità di genere, tutti temi cari alla Gen Z, che fa già parte della forza lavoro delle aziende ed è molto più sensibile alle tematiche sociali rispetto alle generazioni precedenti.
Ma quali caratteristiche deve avere un leader per far fronte alle nuove sfide e chi bisogna preferire tra un Ceo interno e uno esterno?
La scelta di un nuovo amministratore delegato rappresenta una fase cruciale per l’azienda e il dibattito spesso si gioca tra un Ceo interno, che conosce già le sfide e i valori dell’impresa, e un Ceo esterno, portatore di una visione nuova. Un recente studio condotto da Tingyu Du, dottoranda presso la Ucla Anderson School of business e diffuso dal Wall Street Journal, suggerisce che i leader più efficaci sono i cosiddetti «Ceo ibridi», ossia dirigenti che gestiscono una delle filiali dell’azienda, ma non hanno un ruolo di leadership nella società madre. Il loro background consente loro di essere particolarmente efficaci durante i periodi di turbolenza economica o industriale.
Esaminando i dati di 1.450 aziende pubbliche statunitensi dal 1993 al 2017, Du ha scoperto che un terzo delle transizioni nei Cda ha coinvolto Ceo ibridi e che le aziende hanno maggiori probabilità di scegliere un Ceo ibrido durante i periodi di instabilità. Secondo i dati, il 34,9% dei Ceo di nuova nomina erano ibridi in ambienti ad alta turbolenza rispetto al 30,9% in ambienti a bassa turbolenza. «I Ceo ibridi ottengono risultati migliori rispetto agli addetti ai lavori o agli esterni perché, da un lato, conoscono la cultura e le capacità dell’azienda e, dall’altro, hanno una mentalità da outsider, sono più aperti a nuove idee e non hanno fatto parte della sede centrale».
«Ho scoperto che i Ceo ibridi sono disposti a prendere decisioni difficili in quanto sono più aggressivi riguardo ai licenziamenti a confronto degli interni e tanto quanto gli esterni», spiega al Wsj la studiosa. «In termini di taglio delle spese in conto capitale, sono i più aggressivi e, insieme ai licenziamenti, ciò si traduce in migliori prestazioni aziendali». Bob Bruner, preside in pensione della Darden Graduate Business school all’Università della Virginia a Charlottesville, dalle colonne del Wsj mette in guardia dal considerare i Ceo ibridi una panacea in termini di prestazioni aziendali. «Vorrei far notare che molti titoli “tornano indietro” dopo un episodio di duro tumulto economico: in termini statistici, si chiama ritorno alla media». «Prima della crisi», ribadisce Du, «le aziende con Ceo ibridi hanno ottenuto più o meno gli stessi risultati di quelle con insider, ma i Ceo ibridi hanno raggiunto risultati migliori dopo la crisi, e le aziende con Ceo esterni hanno effettivamente ottenuto risultati leggermente peggiori di quelle con Ceo ibridi prima della crisi finanziaria, eppure non si sono «riprese». In generale, conclude, gli ibridi sono quelli da nominare «quando le aziende hanno bisogno di alcuni cambiamenti, ma non troppo».
Può funzionare nelle multinazionali statunitensi. In Europa si cercano creatività e competenze
«La figura del Ceo ibrido mi convince poco, soprattutto perché fa riferimento alle multinazionali statunitensi che hanno una struttura molto articolata, diversa dalle aziende italiane», spiega Gianmario Verona, professore ordinario di Management all’Università Bocconi e presidente della Fondazione Human Technopole, autore del saggio Capaci di decidere. Prospettive e buone pratiche dai leader di oggi per i leader di domani, edito da Egea. «Credo che non esista una soluzione semplice e che anzi la domanda sia mal posta: chi parla di Ceo interno o esterno fa un cattivo servizio a chi deve scegliere. Il Ceo esterno porta vivacità rispetto ai cambiamenti del mercato, quello interno dà una garanzia di continuità. Ma il vero tema è cercare di capire il contesto e lavorare sulle competenze. Oggi siamo di fronte a una costante turbolenza. La parola permacrisi, che nel campo delle scienze sociali e dell’economia è chiamata complessità, è diventata parte del vocabolario comune. Da vent’anni esistono tante variabili interdipendenti che si muovono in modo asincrono, molto velocemente, e che non è possibile prevedere. E i piani strategici delle aziende, che dovrebbero fornire gli orizzonti di medio-lungo termine, diventano sempre più sfidanti».
«Il leader», prosegue l’ex rettore dell’Università Bocconi, «deve avere una sensibilità nei confronti della complessità, cioè fare quello che si chiama problem framing. In un mondo semplice esiste una soluzione per ogni problema, nel mondo complesso di oggi bisogna approcciare le sfide con creatività e pazienza. Il piano strategico non è più un percorso lineare, ma un viaggio da intraprendere lungo la doppia traiettoria del digitale e della sostenibilità, dove per raggiungere gli obiettivi occorre aggregare il capitale umano migliore. Le leadership autoritarie appartengono al passato. I leader devono avere capacità di ascolto, doti empatiche e di engagement per saper giocare di squadra con deleghe verticali e separate. È un lavoro faticoso e di continuo coaching. Per certi aspetti il Ceo moderno è un super direttore del personale. Si tende sempre a delegare a livello istituzionale questo ruolo, ma al di là della parte operativa il vero leader è un super psicologo che per primo sa coordinare le persone, capire il contesto e aggregare le competenze adatte». Solo così sarà possibile migliorare la capacità di gestione delle crisi, che in futuro saranno sempre più ravvicinate nel tempo, diffuse nello spazio e pervasive.